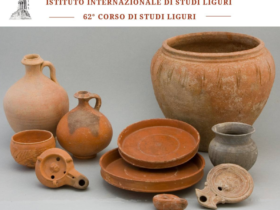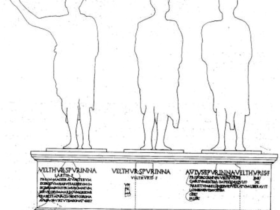Mario Zaniboni. La batteria di Bagdad.

Nel 1938, in un villaggio nei pressi di Bagdad in Iraq, precisamente nel villaggio denominato Khuyut Rabbou’a, capitò all’ingegnere tedesco Wilhelm König, archeologo del Museo Nazionale dell’Iraq, mentre eseguiva scavi in un sito archeologico sasanide, di trovarsi fra le mani un oggetto di terracotta con all’interno elementi metallici. Incuriosito, ne fece un esame approfondito, giungendo alle conclusioni che furono riportate in un libretto, successivamente pubblicato a Berlino nel 1940, secondo le quali si trattava di una cella galvanica che ci proveniva dalla lontana antichità ed ipotizzò pure che questa sarebbe stata proficuamente usata per placcare oggetti in argento con una sottilissima patina d’oro, trovati in abbondanza in Iraq.
E così, quel reperto fu chiamato la “Batteria di Bagdad”, di cui egli stabilì che la data di produzione ricadeva nel il periodo del governo della dinastia dei Parti, cioè dal 247 al 224 a.C.; secondo altri, è un po’ più giovane. Infatti, il dottor John Simpson del Britisch Museum del Vicino Oriente contesta sia il sito sia la stratigrafia del ritrovamento ritenendo che siano stati malamente registrati e, sempre stando a quanto da lui pensato, facendo riferimento allo stile del contenitore che ricorda la ceramica sasanide (il periodo dura fino al 650 d.C.), con ogni probabilità il manufatto è più recente. L’esame del rame e del ferro non consente una corretta datazione, mentre quello della teracotta non direbbe altro che questa è posteriore, il che non aiuta per niente.
Il manufatto era un piccolo contenitore in terracotta alto, 14 centimetri, all’interno del quale si trovava un cilindro formato da una sottile lamina di rame arrotolata dentro la quale era una barretta di ferro; i due oggetti erano isolati fra di loro per mezzo di un tappo di asfalto, ma che non impediva la possibilità di introdurre nel cilindro del liquido elettrolitico. E infatti, esaminando il loro stato di corrosione, gli studiosi sono giunti alla convinzione che questa era dovuta ad una sostanza liquida a base di aceto, succo d’uva o succo di limone: qualcosa, insomma, di naturale.
Il ferro ed il rame danno luogo ad una coppia elettrochimica, intendendo con ciò che, se i due vengono messi in contatto per mezzo di un elettrolita, si genera una differenza di potenziale che un voltmetro riesce a captare. E, poiché in diversi scavi archeologici fatti in Iraq si sono trovati oggetti in argento ricoperti con un leggerissimo velo d’oro, non è stato difficile fare due più due, cioè concludendo che gli antichi orafi usavano più celle di quel tipo per ottenere il voltaggio richiesto per quell’operazione.
Più tardi, nel 1745, ci furono le prove di Villard Gray che dimostrò vera la possibilità di usare il succo d’uva a quello scopo, mentre W. Jansen disse che usò aceto, ottenendo risultati ancora più significativi.
Però, con il trascorrere del tempo, l’ipotesi della placcatura ottenuta in tal modo perse via via credito, tanto che si è giunti al convincimento che la placcatura d’oro si fosse ottenuta solamente attraverso operazioni a fuoco con l’intervento del mercurio. Del resto, considerando le prove effettuate da Erne Eggelbrecht, ci si è resi conto che, per ottenere l’elettroplaccatura dell’argento con uno spessore di oro di un micrometro, le celle dovevano essere veramente molte: pertanto, l’operazione non era per niente alla portata della Batteria di Bagdad. E, proprio per questo, Paul Keyser espresse l’opinione secondo la quale il manufatto serviva semplicemente ai sacerdoti per stupire i fedeli, facendola agire su statue metalliche.
Insomma, per concludere si può affermare che, sì, l’oggetto in esame potrebbe essere stato usato per la placcatura, ma la sua debolezza non lo confermerebbe.
In ogni modo, i dubbi che dominavano le menti degli studiosi sono rimasti tutti, con la speranza che nel futuro qualcuno abbia qualche freccia all’arco che dipani, finalmente, la matassa.
Autore: Mario Zaniboni – zamar.22blu@libero.it